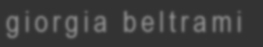
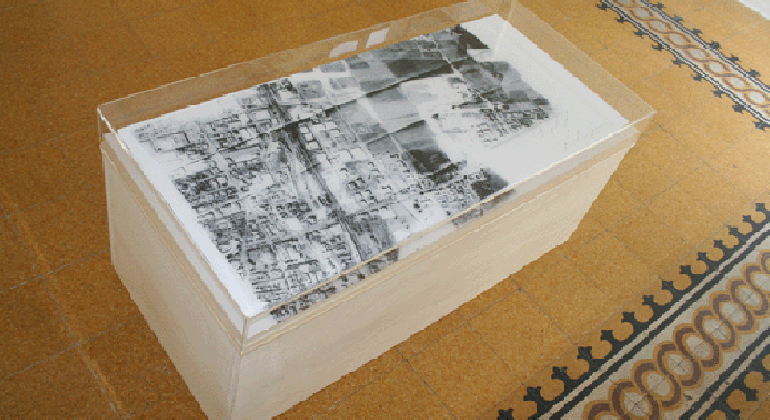
Triologia, Volume III, Maggio 2007, Galleria delle Battaglie, Brescia
TRIOLOGIA
di Alberto Zanchetta
( dal catalogo della collettiva . G. Beltrami F.Guerri L. Piovaccari )
Che ne è stato dell'idilliaco Voyage en Italie ? Cos'è rimasto dei centri della cultura, dei musei a cielo aperto, dei luoghi di pellegrinaggio? Annone - spiega Paul Morand - è stato «il primo viaggiatore; da lui in poi, fin verso la fine del XIX secolo, quando la terra smise di essere sconosciuta, ogni spostamento ebbe uno scopo», il tempo è dunque scaduto? All'incantamento segue l'incatenamento, i ceppi ai piedi ci obbligano a tornare per prendere coscienza di ciò che ci siamo lasciati alle spalle? Arrestando il voyage subentra il passivo voyeur, ed inevitabilmente la visione si sposta verso la periferia, la più anonima. In parte ancora agreste, ma destinata a morire, perché l'uomo nutre l'impellente necessità di realizzarsi mediante l'architettura: dovunque sia, per sentirsi dappertutto in casa propria (così Kiesler spiegava il concetto di abitare). Ora che la sua integrità è stata brutalmente intaccata, sarebbe alquanto sconfortante credere che rimarranno soltanto i cimiteri ad accogliere i frutti proibiti. Le istruzioni per l'uso sembrano andate perdute già da molti anni, il paesaggio che meglio conosciamo e frequentiamo è dunque vessato da interventi architettonici e di urbanistica, principia/actus di desertificazione, depauperazione della vegetazione; grisaille che non a caso [d]enuncia i colori tipici dell'edilizia, e fa da legante ai tre artisti della mostra. Balzato agli onori della critica per le sue fotografie su lucido che destabilizzano la percezione, da diversi anni Piovaccari privilegia interventi installativi e realizza dei delicati pastelli a olio su carta, modalità che ne approfondiscono il razionalismo silente, desolato, solitario. Come dice lui stesso, a interessarlo è «L'ambiguità tra naturale e artificiale che si sostituiscono e si alternano, ma anche la forza della natura che persiste in un ambiente più ostile per la presenza umana»; ogni sua opera di interroga sul degrado ambientale cui il paesaggio è stato sottoposto, sia che si tratti dell'asfittico impatto architettonico oppure delle strade e dei cavi dell'alta tensione che nei piccoli pastelli seguono il punto di fuga (sempre ammesso che una via d'uscita esista ancora). La ricognizione nei territori della Romagna fatta da Luca Piovaccari si riconnette con geografica continuità all'indagine che Giorgia Beltrami conduce nell'Emilia. I suoi bucolici Orizzonti ci mostrano una realtà inesorabilmente contaminata da antenne, ripetitori, cantieri, che l'artista evidenzia con un rosso squillante, quasi fossero degli errori rispetto alla sintassi del paesaggio rurale. Particolare corroso e corrusco che accentua la sua difformità rispetto al contesto; ciò nonostante, l'inequivocabile dimestichezza con cui riescono a integrarsi nella natura li rende più comuni e più immanenti di una derrata. Non da ultimo, Beltrami ci mostra una topografia dove ha appuntato degli spilli, con la capocchia immancabilmente rossa, a indicare il luogo dei suoi "reperti" (difficile catalogarli persino nell'archeologia industriale), elementi dissonanti, senza più remore o ritrosie. Niente è perenne, tutto è transeunte? Venuta meno la reticenza della natura, l'indeterminatezza potrebbe trasformarsi in compresenza, finanche in coesione. Ne sono la riprova i quadri di Federico Guerri. Con un sottile tratto a grafite l'artista delinea degli agglomerati urbani che gravitano nelle nivee campiture delle tele: presenze eteree, essenziali, in cui l'infittirsi dei segni produce un brulicare delle forme. Sono spazi e luoghi generati dall'immaginazione, che mantengono pur tuttavia un evidente richiamo alla morfologia del reale. Secondo Emilio Villa «nella memoria delle palafitte c'è molto che può diventare materia di una breve e costernata superfici di pittura, ma pittura per modo di dire», Guerri potrebbe quindi ereditarne il mimetismo errante, con quel disegno arborescente che vuole emendare le colpe dei costruttori grazie all'agrément artistico. Anziché vivere in clandestinità, la stratificazione non vuole alterare l'equilibrio della realtà ma adattarsi all'esperienza quotidiana, al suo ciclo vitale. Diversamente da Piovaccari e Beltrami che potrebbero accettare la definizione di peintre de la vérité, Guerri si pone in digiuno e in ritiro dal verum et factum per riscattare le sorti di un viaggio che strenuamente chiede l'ultimo commiato.